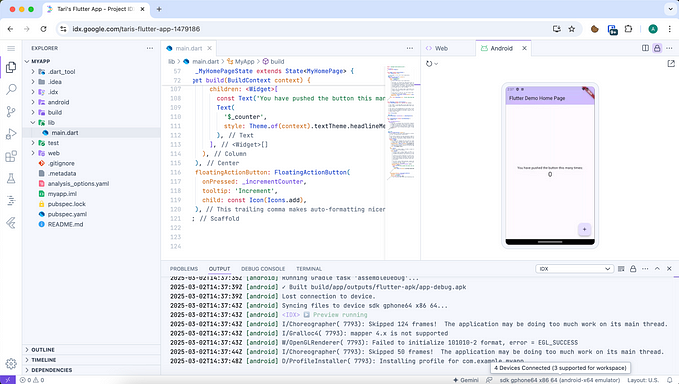Rock e libertà
Più libertini che rivoluzionari.

Libertà (s. f.) — Esenzione da un piccolo numero di vincoli tra gli infiniti imposti all’uomo.
Libertino (s. m.) — Letteralmente un uomo liberato che pertanto è libero di essere schiavo delle sue passioni.
Ambrose Bierce — Devil’s Dictionary
Popolare soprattutto negli anni Sessanta, la “canzone di protesta”, che vede in Dylan il suo profeta supremo, consacrato persino dal Nobel, affronta solo una piccola parte del concetto di libertà.
Nel rock e nel pop si rivendica il diritto collettivo alla libertà sociale, culturale, politica e religiosa, ma soprattutto, e molto più spesso, il diritto individuale di:
• rompere ogni legame con una società opprimente;
• rifuggire da obblighi di qualsiasi genere;
• sperimentare ogni tipo di sostanza lecita e illecita;
• indulgere in relazioni sessuali di ogni genere, incluse quelle con gli alieni.
L’ironico testo di (I married a) Monster from outer space, brano punk del 1978, di J.C. Clarke, tratta il tema scanzonatamente e come piccola rivendicazione contro il conformismo: «I fell in love with an alien being whose skin was jelly — whose teeth were green… We walked out — tentacle in hand, you could sense that the earthlings would not understand… Is bad enough with another race, but fuck me, a monster from outer space».
La strada a questo genere di ironia era stata aperta dalla generazione precedente, quella del boom post-bellico dei bambini nati negli anni Quaranta che si ritrovarono a essere una delle generazioni più privilegiate della storia occidentale, se non la più privilegiata.
Si trattava della prima generazione di giovani cresciuta nella pace e nella prosperità. Mai prima di allora l’accesso a cibo, istruzione, intrattenimento e cultura era stato così capillare. Anche il livello di democrazia e libertà era relativamente alto, dopo decenni di dittature e due guerre che avevano sconvolto il mondo.
La reazione della gioventù occidentale benestante, ben nutrita e istruita degli anni Sessanta fu di prendere per scontati i loro abbondanti diritti e privilegi e contestare per averne ancora di più o, quanto meno, per condividerli con i meno fortunati. C’era probabilmente una buona dose di generosità e ottimismo in quella generazione, ma anche una notevole dose di arroganza. Il cosiddetto Youthquake degli anni Sessanta, oltre a stravolgere la storia del mondo creò una scena musicale variegata e complessa.
Negli Stati Uniti la situazione sociale era esplosiva e oltre al pop e rock più leggero dei Beach Boys e di Elvis, fioriva la musica di protesta di Bob Dylan, di Joan Baez, dei Grateful Dead e di molti altri. La produzione di Dylan è vastissima e soprattutto nei primi anni Sessanta dedicata ai temi della rivoluzione e della libertà. Nel 1962 Dylan scrive uno dei suoi tanti capolavori, Blowin’ in the Wind, in cui si domanda cosa renda libero un uomo. Forse sentire il pianto dei suoi simili e capire che già troppi sono morti per i propri ideali?
Nel 1964 sempre Dylan scrive Chimes of Freedom, un’intricatissima ballata in supporto ai poveri e agli oppressi di questo mondo, che però non avrà la stessa risonanza della più lineare e classica Blowin’ in the Wind. Nel giro di due soli anni e come menzionato da Dylan stesso, The Times They Are A-Changin’, l’interesse popolare — e i testi — si spostano dal sociale al privato.
Nel Regno Unito invece la gente era più occupata a godersi la vita, dopo gli anni duri della guerra e del razionamento post-bellico. Di conseguenza, erano molto più in voga i Beatles, i Rolling Stones e i gruppi che esploravano la psichedelia, l’uso di droghe e il piacere di essere giovani. In I’m Free del 1969, gli Who, già autori di My Generation in cui annunciavano il loro desiderio di morire giovani, celebravano un uomo libero di “esplorare i propri limiti”, in termini vaghi e ambigui: «I’m free and freedom tastes of reality, and I’m waiting for you to follow me». Forse regnava già una certa confusione tra gli ideali di una generazione che non sapeva cosa farsene di tutta quella libertà.
Oltreoceano i testi che vertono su temi personali sono più concreti. Scritta nel 1968 da Kristofferson, ma portata al successo da Janis Joplin, Me & Bobby McGee è la storia di una coppia di innamorati poveri e vagabondi che si godono quel poco che hanno fino all’inevitabile separazione: «Freedom’s just another word for nothin’ left to lose. Nothin’, that’s all that Bobby left me, but feelin’ good was easy».
Questa libertà da vincoli sociali e di vita da passare on the road è molto sentita negli Stati Uniti e celebrata in moltissimi pezzi precedenti e successivi, in genere in termini più ottimistici, come in Born to be wild degli Steppenwolf.

Il decennio della protesta termina con quella che doveva essere la celebrazione del Movimento e l’inizio di un futuro migliore, ma che si rivela in retrospettiva il grandioso funerale degli anni Sessanta, ovvero il concerto di Woodstock. A causa della disorganizzazione totale dell’evento, il traffico fece ritardare parecchi musicisti e nel pomeriggio del 15 agosto 1969, in attesa del gruppo che avrebbe dovuto aprire il concerto ma che era bloccato nelle code chilometriche, Richie Havens venne scaraventato sul palco a dare il via all’evento.
Dopo aver esaurito il suo repertorio e non sapendo ancora chi avrebbe dovuto seguirlo, Havens improvvisò Freedom sulle note di un vecchio spiritual, cavandosela egregiamente anche in mancanza di un messaggio particolarmente incisivo. Il brano originale era Motherless child e il testo è tutto qui: «Freedom, sometimes I feel like a motherless child, a long way from my home — clap your hands, I gotta telephone in my pajama and can call you from my heart when I need my brother, mother, father, sister».
Non esattamente sofisticate rivendicazioni politiche o profondi concetti filosofici alla Dylan, ma sufficienti per scaldare la platea ed entrare nella storia della musica.
In Italia, il tema della libertà è trattato in modo diverso. La scena degli anni Sessanta segue abbastanza da lontano gli sviluppi musicali dei Paesi anglofoni, ma nel 1973 Gaber scrive un pezzo esplicitamente intitolato La Libertà, che affronta il tema da un punto di vista originale, ampliando il discorso toccato occasionalmente dai cantautori anglosassoni. Gaber ci fa notare che la libertà non consiste nel darsi all’eremitaggio o alla fuga: «La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione». Gaber smonta il mito del buon selvaggio e invita a partecipare alla vita sociale, per proteggere quelle libertà che si danno per scontate.
Nel turbolento panorama sociale e politico italiano degli anni Settanta, più che di libertà si tratta di contestazione, che tra l’altro blocca anche il flusso di concerti proveniente dall’estero.
Nel 1976 quando la situazione comincia a placarsi e l’Italia riprende i contatti con musica più leggera, Finardi scrive La radio, inno forse troppo ottimistico alle radio libere che possono aprire la mente.
Nel frattempo, il movimento di protesta si era sbriciolato in mille filoni diversi. Una delle molteplici conseguenze della rivoluzione giovanile era stata la libertà sessuale e il rifiuto di rapporti convenzionali, con conseguente esplosione di divorzi e legami multipli e aperti. Parecchie canzoni celebrano con enfasi la (ri)conquistata libertà e la casualità dei rapporti, tra cui vale la pena di ricordare So long Marianne, raffinata celebrazione della fine di un amore.
Soprattutto in quegli anni si va cementando l’immagine del rocker moderno, come il libertino per eccellenza. Dalla austera incarnazione di Bob Dylan si passa rapidamente alle versioni più debosciate, ma molto più sexy, di Jim Morrison, Mick Jagger, David Bowie, Robert Plant, dei bellocci della New Wave, con Duran Duran in testa, fino ad arrivare a Prince, George Michael e Lenny Kravitz.
Gli aspetti politici e sociali della ricerca e del diritto alla libertà stanno scomparendo dal panorama musicale.
Nei primi anni Settanta in Inghilterra bolle un calderone di idee e generi diversi. Il progressive e la psichedelia celebrano più che altro la libertà dalla realtà, mentre il glam rock spalanca la porta alla libertà di espressione sessuale, promossa anche da costumi di scena tra i più audaci e bizzarri mai visti sul palco.
Non si tratta solo di sesso, ma anche di sperimentazione chimica, come ci raccontano i Jefferson Airplane con White Rabbit, Lou Reed con Heroin, Hendrix con Purple Haze, gli Stones con Sister Morphine, Clapton con Cocaine e moltissimi altri. Liberi tutti di farsi e strafarsi.
Negli USA, la protesta è morta e sepolta, ma il tema della libertà come fuga continua a essere celebrato ampiamente, come ad esempio in Born to Run, la canzone-simbolo del Bruce Springsteen di fine anni Settanta. Negli stessi anni, nell’Inghilterra del punk rock, più che di libertà si passa il tempo a sputarsi addosso e a cantare di suicidio, alienazione e disperazione.
Nel decennio successivo vari brani interpretano un’altra faccia della libertà. Dopo le proteste sociali, le sperimentazioni chimiche e sessuali e la rivendicazione del diritto alla fuga, si passa all’egocentrismo del pop, che sforna testi sulla libertà in negativo, celebrando cuori infranti e relazioni fallite, tra cui I want to break free, brano dei Queen del 1984, che entra nell’immaginario collettivo grazie al video di Freddie Mercury vestito con una vezzosa minigonna.
Anche Nothing compares 2 U rientra nel filone “cuori infranti e libertà negativa”. O’Connor piange sconsolata, anche se è libera di fare quello che vuole «Since you been gone I can do whatever I want, I can see whomever I choose, I can eat my dinner in a fancy restaurant but nothing can take away these blues».
La malinconia pervade l’aria anche in Italia, dove il decennio si conclude con un brano di Vasco Rossi per i reduci di varie battaglie. In Liberi Liberi il testo illustra sia la disillusione sulle battaglie sociali, sia la delusione per la vita in generale: «Soddisfatto di me in fondo non sono mai stato, soddisfatto di che, ma va bene così anche se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi siamo noi ma però liberi da che cosa, chissà cos’è. Finché eravamo giovani era tutta un’altra cosa».
Pochi brani illustrano in maniera più ironica il concetto di libertà al capolinea come Freedom! ’90 di George Michael. Degno precursore di un decennio che vedrà il trionfo delle Spice Girls e di Britney Spears (ma anche gli Oasis, i Verve, i REM e i Nirvana), il brano è accompagnato da un video sfacciatamente superficiale a cui partecipano tutte le supermodelle dell’epoca e ci regala un testo ambiguo, contraddittorio e vacuo: «Brand new clothes and a big fat place on your rock and roll TV… All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don’t belong to you and you don’t belong to me».
Rendiamo vere queste menzogne e chiariamo bene che non ci apparteniamo… Insomma, ognuno per sé e liberi tutti. Dopo decenni di contestazioni, sperimentazioni e superamento di ogni limite imposto dalle società precedenti, il rock non ha più niente da rivendicare o proporre.
Del resto, come scriveva Kant: “Un atto libero non è determinato né dalla natura né da alcuna legge, perciò la libertà, non essendo le azioni in alcun modo imposte, è qualcosa di tremendo”. E cosa può essere più tremendo per i libertini del rock di non sapere più come scandalizzare il pubblico?
Di Daniela R. Giusti

QUID è la rivista digitale del Mensa Italia, l’associazione ad alto Q.I., che raccoglie le competenze e le prospettive personali dei Soci, organizzandole in volumi monografici.
Scaricabile gratuitamente da https://bit.ly/QUID_3
QUID nasce con l’ambizione di confrontarsi senza voler ricomporre a tutti i costi un pensiero rappresentativo e prevalente, per proporre una lettura sempre aperta dei temi che stanno a cuore ai Soci del Mensa Italia